Overthinking: quando pensare troppo fa male alla mente

Ti è mai capitato di sentirti intrappolato nei tuoi pensieri? Non sei il solo. Uno studio dell’Università del Michigan ha rilevato che quasi 3 giovani adulti su 4 (25-35 anni) hanno la tendenza a pensare troppo, mentre solo il 20% degli anziani presenta lo stesso problema. Questi numeri suggeriscono che il cosiddetto overthinking, letteralmente pensare troppo, è un fenomeno diffuso e in crescita, che può minare seriamente il nostro benessere mentale.
Indaghiamo su cos’è l’overthinking, perché incide così tanto sulla qualità di vita e come riconoscerne i segnali. Scopriremo cause e fattori di rischio (psicologici e ambientali) e capiremo quando chiedere aiuto a un professionista. Vedremo inoltre quali sono gli approcci di trattamento comprovati (dalle terapie psicologiche alle strategie quotidiane basate sulla scienza) e condivideremo alcuni consigli pratici per gestire i pensieri e smettere di rimuginare.
Capire l’overthinking è il primo passo per imparare a gestirlo.
Cos’è l’overthinking?
Overthinking significa, letteralmente, “pensare troppo”. In psicologia si usa questo termine per indicare un loop mentale di pensieri eccessivi, ripetitivi e difficili da controllare. Chi cade nell’overthinking tende a rimuginare a lungo su eventi passati o futuri senza arrivare a una soluzione concreta. Non si tratta di una riflessione utile, ma di uno stile di pensiero disfunzionale: i pensieri girano a vuoto, alimentano dubbi e preoccupazioni, e finiscono per compromettere la lucidità mentale.
In altre parole, l’overthinking è l’abitudine di focalizzarsi in modo eccessivo e improduttivo su determinati pensieri o problemi. La mente può restare bloccata per ore a chiedersi “Ho fatto la scelta giusta?” oppure a immaginare scenari catastrofici per il futuro. Spesso questi pensieri diventano talmente frequenti e intrusivi da interferire con la vita quotidiana. Se ti riconosci in questa descrizione, per esempio ti senti sovraccarico di pensieri al punto da non riuscire a “spegnere” la mente, potresti trovarti nel circolo vizioso dell’overthinking.
Vale la pena chiarire che “pensare tanto” non equivale a essere più intelligenti o diligenti. Al contrario, come osserva la psicologa Susan Nolen-Hoeksema (pioniera negli studi sulla ruminazione mentale), indulgere costantemente in pensieri su problemi e conseguenze senza passare all’azione tende solo ad aumentare il disagio. Un sano problem solving implica analizzare una situazione e poi agire; con l’overthinking, invece, restiamo incastrati nell’analisi infinita, logorandoci mentalmente. Col tempo, questo chatter interiore incessante può diventare un vero ostacolo al benessere.
Overthinking in termini semplici: immagina la mente come un motore sempre acceso, che però non ingrana mai la marcia giusta. Gira, gira, consuma carburante (energia mentale) ma non ti porta da nessuna parte, anzi, ti lascia stanco e in ansia. Nei paragrafi successivi vedremo perché questo meccanismo incide negativamente su vari aspetti della vita e come riconoscerlo.
Perché l’overthinking incide sulla vita quotidiana?
Pensare è una funzione normale (e preziosa) della mente; tuttavia, pensare troppo a lungo e in modo negativo può diventare debilitante. L’overthinking incide sulla vita in diversi modi:
- Benessere mentale: Il pensiero eccessivo alimenta stress e ansia. Chi rimugina continuamente tende ad amplificare le preoccupazioni, generando un circolo d’ansia difficile da interrompere. Numerosi studi mostrano che ruminare a lungo su eventi negativi è un fattore che contribuisce allo sviluppo di depressione e disturbi d’ansia. In pratica, più rimugini, più ti senti giù o in allarme, il che porta a ulteriore rimuginio, una spirale pericolosa per la salute mentale.
- Capacità di decisione: L’overthinking spesso paralizza il processo decisionale. Analizzando ossessivamente ogni dettaglio e ogni possibile esito (“e se sbaglio?”), si cade nella procrastinazione e indecisione cronica. Il risultato? Si fatica a prendere anche decisioni semplici, con il rischio di perdere opportunità o accumulare ritardi. Questo fenomeno è noto anche come “paralisi da analisi”: la lucidità mentale si offusca e risolvere i problemi diventa arduo perché la mente è bloccata sul problema stesso invece che orientata alla soluzione.
- Relazioni e vita sociale: Chi pensa troppo può avere difficoltà anche nei rapporti con gli altri. Ad esempio, nell’ambito amoroso l’overthinking è un terreno fertile per dubbi e insicurezze: si finisce per interpretare ogni parola o gesto del partner cercando significati nascosti (“Perché ha detto così? Se non mi scrive subito significa che ce l’ha con me?”). Questo circolo vizioso genera facilmente tensione e stress nella relazione, minando la fiducia reciproca e impedendo di vivere il rapporto con serenità. Anche in amicizia o al lavoro, l’abitudine di rimuginare su ogni conversazione o email può portare a malintesi, insicurezza nel comunicare e tendenza all’isolamento.
- Performance e produttività: Una mente sovraccarica è meno efficiente. L’overthinking riduce la concentrazione (si perde il focus continuando a tornare sugli stessi pensieri), rallenta l’esecuzione dei compiti e aumenta il rischio di errori dovuti alla distrazione. Chi pensa troppo spesso riferisce una costante sensazione di “mente annebbiata” e fatica a mantenere la produttività sul lavoro o nello studio. Col tempo ciò può intaccare anche l’autostima: vedendo che non riusciamo a concludere quanto vorremmo, alimentiamo la convinzione di non essere all’altezza, in un loop di auto-svalutazione.

In sintesi, l’overthinking ostacola la nostra capacità di vivere pienamente il presente. Invece di goderci i momenti di quiete, la mente sovreccitata continua a macinare pensieri (spesso negativi), tenendoci in uno stato di allerta costante. È come avere un rumore di fondo mentale che non si spegne mai: ci accompagna mentre cerchiamo di dormire, mentre dovremmo rilassarci o concentrarci su altro. Questo logora il benessere giorno dopo giorno.
Un dato significativo: secondo uno studio pubblicato dall'American Psychological Association, rimuginare continuamente sul lato negativo delle cose crea un ciclo per cui più la persona ruminante si sente male, più continuerà a ruminare, in un meccanismo autoalimentato. Spezzare questo ciclo è fondamentale per ritrovare equilibrio.
Sintomi e segnali di overthinking
Come riconoscere se tu (o qualcuno a te caro) state cadendo nel circolo vizioso del pensare troppo? I segnali dell’overthinking possono manifestarsi su diversi livelli, fisico, emotivo e comportamentale. Vediamoli separatamente per chiarezza.
Sintomi fisici
L’overthinking prolungato può innescare una vera e propria risposta di stress cronico nel corpo. Tra i sintomi fisici più comuni troviamo:
- Tensione muscolare: contratture a livello di collo e spalle, rigidità e dolori alla schiena o cervicale, spesso dovuti allo stato di allerta continuo. Emblematico il mal di testa tensivo, quella morsa dolorosa alla testa e al collo che compare dopo ore di preoccupazioni.
- Disturbi del sonno: difficoltà ad addormentarsi per i pensieri che girano in testa, risvegli notturni frequenti o sonno leggero e non ristoratore. La mente iperattiva fatica a “spegnersi” la sera, causando insonnia. Al mattino ci si sente già stanchi.
- Stanchezza cronica: il super-lavoro mentale prosciuga le energie. Chi rimugina di continuo spesso si sente mentalmente ed emotivamente esausto, con poca energia fisica per affrontare la giornata.
- Disturbi gastrointestinali: stress e mente agitata possono riflettersi sul corpo con tensione addominale, difficoltà digestive, acidità di stomaco o nausea. Esiste una forte connessione mente-intestino: l’ansia e il rimuginio possono alterare i normali ritmi digestivi.
- Altri segnali di stress fisico: palpitazioni o tachicardia (soprattutto durante i picchi di ansia legati ai pensieri), sudorazione, respiro corto, giramenti di testa. In alcuni casi, l’overthinking protratto può contribuire all’aumento della pressione sanguigna o a indebolire le difese immunitarie (il corpo è come se fosse in perenne “modalità attacco-fuga”).
Sintomi emotivi e cognitivi
Sul piano emotivo, l’overthinking si accompagna a una serie di stati d’animo e di effetti psicologici caratteristici:
- Ansia e preoccupazione costante: è il segnale emotivo per eccellenza. La mente è costantemente impegnata in un dialogo interiore fatto di dubbi, what if (“e se...”) e timori spesso irrazionali. Anche senza un motivo preciso, ci si sente in allarme per “qualcosa che potrebbe andare storto”.
- Irritabilità e sbalzi d’umore: avere la mente sempre sovraccarica rende più nervosi e suscettibili. Piccole contrarietà possono scatenare reazioni eccessive o oscillazioni del tono dell’umore (si passa dall’ansia alla frustrazione, talvolta alla tristezza). Si può provare impazienza verso gli altri, perché il fardello mentale rende meno tolleranti.
- Difficoltà di concentrazione: paradossalmente, pur pensando “troppo”, non si riesce a pensare bene quando serve. La mente vaga continuamente, si distrae tornando sui soliti pensieri intrusivi. Studiare, lavorare o anche solo seguire una conversazione diventa impegnativo perché parte del cervello è sempre altrove, impantanato nel rimuginio.
- Sensazione di sopraffazione: molti descrivono la sensazione di avere “la mente in tilt” o di essere sopraffatti dai propri pensieri. È comune provare un senso di impotenza (“non riesco a fermare la testa”) e di autocritica per questo. Questo può accompagnarsi a bassa autostima o senso di colpa, specie quando i pensieri riguardano errori passati.
- Tristezza e demoralizzazione: se l’overthinking è focalizzato su eventi negativi passati (ruminazione) o su scenari futuri catastrofici, può emergere un umore depresso. Rimuginare sul passato alimenta il senso di colpa e il rimpianto; preoccuparsi continuamente del futuro genera paura e pessimismo. Col tempo ciò può sfociare in apatia o disperazione, segnali che il pensiero eccessivo sta erodendo la salute emotiva.
Sintomi comportamentali
Infine, l’overthinking influisce anche sul comportamento e sulle azioni quotidiane. Alcuni segnali comportamentali indicativi sono:
- Procrastinazione e indecisione: la persona rimanda continuamente le decisioni o le attività per paura di sbagliare. Ogni scelta viene analizzata così a fondo (pro e contro, scenari possibili) che si finisce per non scegliere affatto. Questo può riguardare decisioni importanti ma anche piccole cose quotidiane, generando immobilismo.
- Evitamento di situazioni stressanti: chi soffre di overthinking tende a evitare contesti che possano innescare ulteriori pensieri ansiogeni. Ad esempio può evitare conversazioni difficili o decisioni importanti, temendo di non essere all’altezza di gestirle senza andare in crisi di pensieri. A lungo andare, però, l’evitamento restringe la vita della persona.
- Eccesso di richiesta di rassicurazioni: un comportamento tipico è chiedere continuamente conferme agli altri (amici, familiari, partner) per alleviare l’ansia. Ad esempio, una persona insicura può domandare più e più volte “Sei sicuro che vada bene?”, “Cosa ne pensi?”. Questa dipendenza da rassicurazione è un tentativo di placare i dubbi, ma spesso fornisce solo un sollievo temporaneo.
- Riduzione dell’efficacia operativa: a livello pratico, l’overthinker può apparire disorganizzato o inconcludente. Si notano difficoltà a portare a termine i compiti nei tempi previsti (perfezionismo paralizzante), tendenza a ricontrollare ossessivamente lavori già fatti, o a saltare da un’analisi all’altra senza mai agire. Questo può impattare sul rendimento lavorativo o scolastico.
- Segnali di agitazione: alcuni manifestano fisicamente l’inquietudine mentale, ad esempio mordicchiandosi le unghie, giocherellando con capelli o penne, camminando avanti e indietro. Sono comportamenti auto-lenitivi per scaricare la tensione generata dal continuo rimuginare.
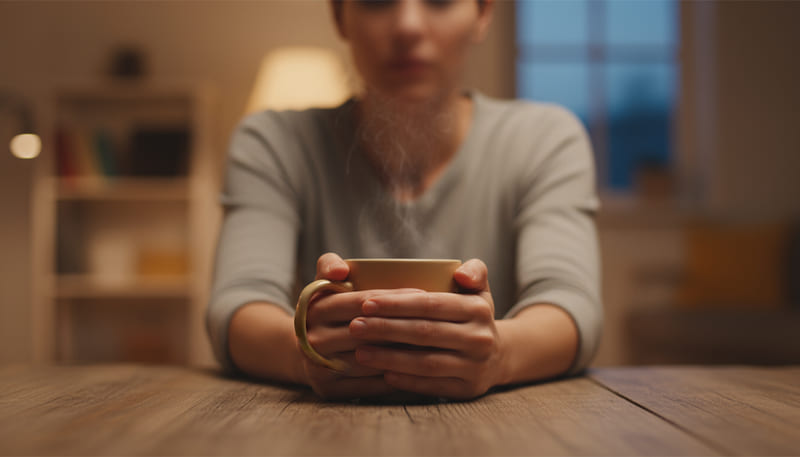
Va detto che tutti quanti, di tanto in tanto, ci preoccupiamo o pensiamo intensamente a qualcosa. La differenza, quando si parla di overthinking, è quantitativa e qualitativa: i pensieri e le preoccupazioni diventano così frequenti, prolungati e difficili da interrompere da causare un significativo disagio. Se riconosci molti di questi sintomi in te stesso e li vivi da parecchio tempo, potrebbe essere utile approfondire le cause e valutare strategie per spezzare questo ciclo (anche con l’aiuto di un esperto, se necessario, come vedremo più avanti).
Cause e fattori di rischio dell’overthinking
Perché alcune persone tendono al pensiero eccessivo più di altre? Le cause dell’overthinking sono spesso multifattoriali, un intreccio di caratteristiche personali, esperienze di vita e contesti. Di seguito, elenchiamo i principali fattori psicologici e ambientali che possono predisporre all’overthinking:
- Indole ansiosa e insicurezza: Chi ha un temperamento ansioso o un basso senso di autoefficacia è più incline a rimuginare. Paura del futuro e insicurezza portano la mente a immaginare scenari negativi e a cercare di prevedere ogni rischio, in un’attività mentale costante. In pratica, se non ci si sente capaci di gestire le sfide, si finisce per ripensare ogni scelta mille volte, alimentando il dubbio invece che la soluzione.
- Perfezionismo e autocritica: Voler fare tutto “alla perfezione” può trasformarsi in un’ossessione. Le persone molto perfezioniste o ipercritiche verso sé stesse tendono a esaminare ogni dettaglio delle proprie azioni temendo l’errore. Questo bisogno di controllo assoluto spinge la mente a non fermarsi mai: ogni decisione viene continuamente rivista e corretta mentalmente, bloccando di fatto l’azione. Il risultato è overthinking cronico, accompagnato da paura di sbagliare e procrastinazione.
- Eventi traumatici o stress prolungati: Un passato di esperienze dolorose può lasciare il segno sotto forma di ipervigilanza mentale. Chi ha vissuto un trauma (ad es. un lutto improvviso, un abuso, un incidente) spesso sviluppa una mente iper-attiva che analizza costantemente le situazioni per evitare di rivivere quel dolore. L’area cerebrale dell’amigdala, coinvolta nelle risposte emotive di allarme, rimane in stato di allerta e facilita la comparsa di pensieri ricorrenti e immagini intrusive legate al trauma. Anche periodi di forte stress cronico (es. mobbing sul lavoro, difficoltà economiche prolungate, pandemia) possono predisporre al pensiero ansioso e ripetitivo.
- Ambiente familiare e stile educativo: Crescere in un ambiente molto critico o iper-esigente può incoraggiare l’overthinking. Se da bambini ogni errore veniva ingigantito o punito severamente, da adulti si può interiorizzare la tendenza a ruminare su ogni scelta per paura delle conseguenze. Al contrario, un ambiente che non insegna a gestire lo stress o le emozioni potrebbe lasciare i giovani senza strumenti, portandoli a cercare di risolvere tutto rimuginando mentalmente. Le aspettative sociali (performance scolastiche, successo lavorativo) e la cultura del “sempre attivi” possono anch’esse creare terreno fertile per l’overthinking, facendo percepire ogni incertezza come intollerabile.
- Fattori di personalità e genetici: Alcune persone sono per natura più inclini all’introspezione e alla preoccupazione. Tratti di personalità come il nevroticismo (tendenza a provare ansia, insicurezza, emotività negativa) correlano con la propensione a ruminare. Anche fattori biologici possono giocare un ruolo: squilibri di alcuni neurotrasmettitori (come serotonina e dopamina) sono stati associati sia all’ansia/depressione sia al pensiero ossessivo. Tuttavia, va sottolineato che nessuno nasce “overthinker” in senso stretto, si tratta più di un meccanismo appreso e rinforzato nel tempo, che può quindi essere modificato con le giuste strategie.
- Età e genere (fattori di rischio demografici): Studi indicano che l’overthinking colpisce di più i giovani adulti rispetto agli anziani. Le persone tra 20 e 35 anni riferiscono livelli di rimuginio significativamente maggiori rispetto agli over-65 (73% vs 20% in una ricerca citata). Ciò potrebbe dipendere dallo stile di vita moderno iper-stimolante e dalle pressioni (studio, carriera, relazioni) tipiche dell’età adulta giovane. Inoltre, le donne sembrano più predisposte degli uomini al pensiero eccessivo e alla ruminazione. La differenza potrebbe avere basi sia socioculturali (ruoli di genere che incoraggiano le donne a preoccuparsi di più) sia biologiche (alcune ricerche di neuroimaging mostrano un’attivazione cerebrale diversa nei due sessi sotto stress). In ogni caso, il dato di fatto è che genere femminile e giovane età sono considerati fattori di rischio per l’abitudine di overthinking (anche se ovviamente ogni individuo è un caso a sé).
Va ribadito che l’overthinking non nasce mai dal nulla. Spesso è la risultante di più fattori concomitanti: ad esempio una persona ansiosa e perfezionista, che vive un periodo di stress lavorativo, potrebbe sviluppare più facilmente il circolo di pensiero ossessivo. Comprendere le cause alla base di questo meccanismo è importante perché costituisce il primo passo per imparare a gestirlo. Ad esempio, riconoscere che il proprio rimuginare deriva da una bassa autostima o da un trauma irrisolto significa poter lavorare su questi aspetti mirati in terapia.
Quando chiedere aiuto: il confine tra abitudine e disturbo
Tutti riflettiamo sulle nostre scelte o ci preoccupiamo di tanto in tanto. Quindi, quando l’overthinking diventa un problema da affrontare con un professionista? Ecco alcuni criteri chiari per capire quando chiedere aiuto:
- Persistenza e pervasività: Se ti accorgi che i pensieri eccessivi sono quasi quotidiani e durano da mesi, e non riguardano solo un periodo circoscritto (es. un esame importante, un trasloco), allora l’overthinking non è più occasionale ma è diventato parte stabile della tua vita. In particolare, se anche in momenti che dovrebbero essere rilassanti (come nel weekend o in vacanza) la tua mente non “stacca mai”, è un segnale d’allarme.
- Impatto sul funzionamento quotidiano: Chiediti onestamente se il pensare troppo sta interferendo con le tue attività e relazioni. Hai difficoltà a svolgere il lavoro o a studiare perché non riesci a concentrarti? Rimandi spesso impegni o decisioni importanti a causa dell’ansia? Le tue relazioni ne risentono (ad es. litigi frequenti dovuti a fraintendimenti o gelosie alimentate dall’overthinking)? Se la risposta è sì, significa che l’overthinking è diventato un ostacolo nel normale svolgimento della tua vita.
- Sofferenza emotiva significativa: Un criterio fondamentale è il livello di disagio che provi. Ti senti esaurito, frustrato, magari disperato perché “non riesco a smettere di pensare”? L’overthinking ti causa frequenti attacchi d’ansia, momenti di pianto, insonnia grave? Se il grado di sofferenza psicologica è alto e continuativo, è opportuno cercare un aiuto professionale. Nessuno merita di vivere prigioniero della propria mente, e se così ti senti è il momento di parlarne con qualcuno.
- Fallimento delle strategie fai-da-te: Magari hai già provato alcuni rimedi da solo, come distrarti, fare sport, praticare meditazione, ma nulla sembra funzionare a lungo termine. Oppure riesci a calmare i pensieri per qualche ora o giorno, ma poi ricadi sempre nello stesso loop. Quando gli sforzi autonomi non bastano, significa che la problematica richiede un intervento più mirato e strutturato (come una psicoterapia).
- Segnali di disturbi specifici: Come accennato, l’overthinking a livelli estremi può essere sintomo di un disturbo mentale sottostante. Ad esempio, il disturbo d’ansia generalizzata (GAD) si caratterizza proprio per preoccupazioni eccessive su molteplici temi, difficili da controllare. Nel disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) sono presenti pensieri intrusivi persistenti (ossessioni) che ricordano molto l’overthinking. Anche nella depressione spesso si osserva ruminazione costante su eventi passati, così come nel disturbo da stress post-traumatico compaiono pensieri intrusivi sul trauma. Se oltre all’overthinking noti sintomi tipici di queste condizioni, ad es. ansia intensa e irrealistica, rituali compulsivi, umore depresso marcato, flashback traumatici, è fondamentale rivolgersi a uno specialista. Solo un professionista potrà fare una diagnosi accurata e distinguerà se il “pensare troppo” è parte di un quadro clinico più ampio.
In generale, un buon indicatore è questo: quando senti che i pensieri ti controllano, anziché essere tu a controllare loro, vale la pena chiedere aiuto. Non c’è debolezza nell’affidarsi a un esperto; al contrario, è un atto di coraggio e di cura verso te stesso. Moltissime persone scoprono, grazie alla terapia, che la propria tendenza al rimuginio era il campanello d’allarme di un disagio più profondo (ansia, insicurezze, traumi) che poteva essere affrontato e risolto.
Ricorda che chiedere aiuto per l’overthinking è assolutamente legittimo. Se pensi che questo problema stia limitando la tua vita, parlarne con uno psicologo o uno psicoterapeuta può farti ritrovare un senso di chiarezza mentale ed equilibrio. Non devi aspettare di “toccare il fondo”: intervenire per tempo rende il percorso di uscita dall’overthinking più breve ed efficace.
Approcci di trattamento dell’overthinking
Superare l’overthinking è possibile, soprattutto utilizzando strategie di comprovata efficacia derivate dalla psicologia clinica. Di seguito esamineremo i principali approcci di trattamento raccomandati, dalle terapie con evidenze scientifiche alle eventuali terapie farmacologiche, sottolineando l’importanza, nei casi più seri, di un approccio multidisciplinare. L’obiettivo è rompere il circolo vizioso dei pensieri continui e restituire alla persona il controllo sulla propria mente.
Psicoterapia e tecniche cognitivo-comportamentali
Il trattamento d’elezione per l’overthinking è la psicoterapia, in particolare ad indirizzo cognitivo-comportamentale. La Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT) è considerata la più efficace per intervenire su pensieri ossessivi, ruminazione e preoccupazioni croniche. In sintesi, la CBT aiuta a identificare e modificare quei pensieri distorti o inutili che alimentano il malessere. Nel caso dell’overthinking, il terapeuta lavora con il paziente per riconoscere i pattern di pensiero negativo (ad esempio generalizzazioni catastrofiche tipo “Andrà tutto male”) e sostituirli con valutazioni più realistiche e funzionali. Si imparano tecniche di ristrutturazione cognitiva: la persona prende consapevolezza dei propri bias mentali e viene guidata a mettere in discussione le previsioni catastrofiche, valutando le prove a favore/contrarie e formulando pensieri alternativi più equilibrati.
Nei casi in cui l’overthinking si presenta in forme affini al DOC (disturbo ossessivo-compulsivo), può essere indicata una specifica tecnica comportamentale chiamata Terapia di Esposizione con Prevenzione della Risposta (ERP). Questa terapia, spesso integrata nella CBT, consiste in due fasi: l’esposizione graduale ai pensieri temuti (il paziente, con l’aiuto del terapeuta, “affronta” volontariamente le idee che solitamente innescano il rimuginio) e la prevenzione della risposta (si lavora per evitare le solite reazioni disfunzionali, ad es. analizzare all’infinito o mettere in atto comportamenti di rassicurazione). In pratica, la ERP insegna a tollerare l’ansia prodotta da certi pensieri senza ricorrere al loop di overthinking come falsa strategia di controllo. Con l’esposizione ripetuta, i pensieri perdono potere e l’ansia si riduce nel tempo. La ricerca mostra che questo approccio è molto efficace soprattutto quando l’overthinking è legato a ossessioni ansiose o fobie.
Un altro insieme di tecniche utili proviene dalla terapia metacognitiva e dall’Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ad esempio, la defusione cognitiva, concetto chiave dell’ACT, è spesso insegnata per gestire l’overthinking. Consiste nell’imparare a vedere i pensieri per quello che sono (semplici eventi mentali) e non come verità assolute o minacce reali. Distanziare se stessi dai propri pensieri (defondersi) aiuta a ridurre l’impatto emotivo di quei pensieri e a osservarli con maggior obiettività. In terapia, attraverso esercizi mirati, la persona sviluppa la capacità di lasciare andare un pensiero intrusivo senza “agganciarvisi” ogni volta.
Molto importante è anche l’insegnamento della mindfulness e di altre tecniche di gestione emotiva. La mindfulness (consapevolezza del momento presente) aiuta a radicarsi nell’“qui e ora” e a interrompere il flusso di pensieri automatici. Esercizi di respirazione, meditazione guidata e rilassamento muscolare progressivo sono spesso integrati nel percorso terapeutico per fornire al paziente strumenti pratici con cui calmare la mente quando tende a vagare nel loop di pensieri negativi ricorrenti.
Giova ricordare che la terapia non dà risultati immediati, ma con un lavoro costante su di sé, supportato dal terapeuta, è possibile spezzare le ruminazioni e il rimuginio. Si impara ad accogliere il proprio passato (anziché riviverlo con angoscia) e a gestire meglio le preoccupazioni sul futuro, sviluppando un atteggiamento più flessibile e orientato all’azione concreta. In altre parole, la psicoterapia aiuta la persona a riorganizzare i propri pensieri, a rimettere in prospettiva paure e sensi di colpa, e infine a ritrovare la chiarezza mentale.
Approccio multidisciplinare e supporto farmacologico
In molti casi, soprattutto quando l’overthinking è molto intenso e persistente, il percorso ottimale è quello multidisciplinare. Ciò significa coinvolgere diverse figure professionali (psicologo/psicoterapeuta, psichiatra, ecc.) per affrontare il problema su più fronti. Le linee guida internazionali per i disturbi d’ansia e correlati raccomandano spesso una combinazione di terapia psicologica e, se necessario, terapia farmacologica.
Sul fronte farmacologico, non esiste un farmaco “per l’overthinking” in sé (non essendo un disturbo codificato), ma si interviene sui sintomi correlati: ansia, insonnia, depressione, ecc. Uno psichiatra potrebbe prescrivere, ad esempio, ansiolitici o antidepressivi SSRI se l’overthinking fa parte di un quadro di ansia generalizzata o depressione. I farmaci aiutano a ridurre l’intensità dei sintomi (abbassando il livello di ansia di base, migliorando il sonno, stabilizzando l’umore) così che la persona possa poi lavorare più efficacemente in terapia psicologica. È importante sottolineare che la terapia farmacologica va sempre valutata caso per caso e affiancata, non sostituita, da un percorso psicoterapeutico. I farmaci infatti alleviano i sintomi, ma non insegnano le strategie mentali per evitare di ricadere nel circolo vizioso; queste ultime si acquisiscono con la terapia e la pratica personale.
In un approccio integrato, possono essere coinvolti anche altri professionisti della salute: ad esempio, un medico internista per escludere che i sintomi fisici (stanchezza, tachicardia, disturbi del sonno) abbiano cause organiche, oppure un nutrizionista se l’ansia ha impatto sull’alimentazione (abbuffate emotive o calo ponderale). Alcune cliniche del benessere mentale, come My Mental Care, adottano proprio un team multidisciplinare (psicologi, psichiatri, nutrizionisti, ecc.) per offrire al paziente un supporto completo a 360°.
Un recente studio pubblicato sul Journal of Clinical Psychiatry evidenzia il valore di un approccio combinato per trattare fenomeni come ruminazione e pensiero ossessivo: integrare psicoterapia, farmacoterapia e interventi sullo stile di vita fornisce risultati migliori nel ridurre il rimuginio e prevenire le ricadute. In pratica, mente e corpo vengono aiutati insieme: si agisce sui pensieri con la terapia, sul cervello con eventuali farmaci, e sulle abitudini quotidiane con consigli di lifestyle (come quelli che vedremo a breve). Questa sinergia aumenta le probabilità di successo del trattamento.
In sintesi, il messaggio chiave è che non bisogna avere timore di chiedere aiuto professionale per l’overthinking. Già dopo poche sedute di terapia, molte persone riferiscono un senso di sollievo: finalmente qualcuno dà un nome a quello che provano e fornisce strumenti concreti per stare meglio. E se serve coinvolgere uno psichiatra per un periodo, ciò non significa “essere matti”, ma semplicemente utilizzare tutte le risorse disponibili per guarire. Lo scopo ultimo è ridare alla persona la padronanza della propria mente, eliminando quei pensieri eccessivi che tolgono energia e serenità.
Strategie pratiche per smettere di pensare troppo
Oltre ai percorsi terapeutici professionali, esistono alcune strategie pratiche che chiunque può adottare nel quotidiano per gestire l’overthinking e ridurne l’impatto. È importante sottolineare che questi consigli hanno una base scientifica: non sono “rimedi della nonna”, ma tecniche suggerite da psicologi e supportate da studi sul benessere mentale. Di seguito presentiamo 5 semplici strategie (max) che puoi provare fin da subito:
- Fare attività fisica (meglio se all’aria aperta): L’esercizio fisico regolare è uno dei modi più efficaci per calmare una mente iperattiva. Muoversi aiuta a scaricare la tensione e stimola il rilascio di endorfine, neurotrasmettitori che migliorano l’umore. Studi scientifici hanno rilevato che basta una singola sessione di esercizio per ridurre significativamente i sintomi di rimuginio. Se poi l’attività si svolge nella natura, i benefici aumentano: ad esempio, dopo 90 minuti di camminata in un parco, le persone riportano molti meno pensieri negativi ripetitivi rispetto a prima. Dunque, prova a inserire nella tua routine passeggiate, corsa, bici o qualunque sport ti piaccia. Consiglio: quando senti la testa affollata, esci e fai una camminata a passo svelto concentrandoti sulle sensazioni fisiche (respiro, vento sulla pelle, suoni intorno a te). Aiuta a interrompere il filo dei pensieri.
- Praticare mindfulness e tecniche di respirazione: Imparare a riportare la mente al momento presente è un antidoto potente contro l’overthinking (che per definizione ci porta nel passato o nel futuro). La mindfulness, ovvero la meditazione di consapevolezza, insegna proprio a osservare i pensieri senza farsi trascinare da essi e a lasciarli andare. Anche solo 10 minuti al giorno di meditazione possono ridurre l’ansia e i pensieri intrusivi. Puoi iniziare focalizzandoti sul respiro: siedi comodo, chiudi gli occhi e segui mentalmente l’aria che entra e esce dai polmoni. Quando la mente divaga (perché lo farà!), riconosci il pensiero senza giudicarlo e gentilmente riporta l’attenzione al respiro. Questo esercizio allena il “muscolo” dell’attenzione e, col tempo, ti renderà più facile spegnere il pilota automatico del rimuginio. Oltre alla mindfulness, risultano utili tecniche di rilassamento come la respirazione profonda diaframmatica (inspirando dal naso contando fino a 4, espirando lentamente dalla bocca contando fino a 6-8) o il rilassamento muscolare progressivo di Jacobson. Questi strumenti abbassano l’attivazione fisiologica legata allo stress e aiutano a calmare mente e corpo nei momenti di overthinking intenso.
- Distrarsi con attività piacevoli e sociali: Può sembrare banale, ma staccare dalle proprie preoccupazioni immergendosi in qualcos’altro è un metodo valido per spezzare il flusso dei pensieri negativi. Quando senti che stai iniziando a rimuginare, cambia occupazione: chiama un amico (e parlate di argomenti leggeri), dedica mezz’ora a un hobby che richiede concentrazione (disegnare, suonare, fare giardinaggio), oppure riordina quell’armadio incasinato. L’idea è di interrompere il loop mentale obbligando il cervello a focalizzarsi su altro. Anche impegnarsi in attività sociali aiuta moltissimo: una serata in compagnia, fare volontariato, partecipare a un corso di gruppo, tutte situazioni che portano la mente fuori da sé stessa e la riempiono di stimoli nuovi. La ricerca suggerisce persino di cambiare ambiente quando si è bloccati nei pensieri: uscire di casa e magari recarsi in un luogo che evochi sensazioni positive può ridurre la ruminazione. Ad esempio, se hai un posto preferito (una biblioteca, un belvedere, un caffè accogliente), vai lì a leggere o a passeggiare quando la testa è troppo affollata. In breve, non restare fermo a pensare: muoviti, fai, interagisci, il cervello pian piano si “dimenticherà” di quello che lo tormentava.
- Scrivere un diario (e sfidare i pensieri negativi): Mettere per iscritto i propri pensieri è un esercizio terapeutico riconosciuto. Annotare i pensieri su carta aiuta infatti a dare loro una forma concreta e spesso a ridimensionarli. Quando le preoccupazioni restano astratte nella mente sembrano infinite e schiaccianti; scrivendole, si delimita il problema e ci si distanzia un po’ emotivamente. Prova la sera, prima di dormire, a dedicare 5-10 minuti a scrivere tutto ciò che ti passa per la testa. Puoi fare un elenco delle cose che ti preoccupano in quel giorno. Poi rileggi ogni punto e chiediti: “Questo pensiero mi è utile? Mi aiuta a risolvere qualcosa o fa solo rumore?”. Spesso ti accorgerai che molti pensieri sono ripetitivi e sterili. A questo punto puoi applicare una tecnica cognitiva: sfida i pensieri negativi automatici. Ad esempio, se hai scritto “Sono sicuro che fallirò quel progetto”, prova a contestualizzare: quante volte in passato hai temuto di fallire e poi invece te la sei cavata? Ci sono prove reali che andrà male o è solo la tua ansia che parla? Secondo la National Science Foundation, il cervello umano genera tra 15.000 e 50.000 pensieri al giorno e la maggior parte di essi, fino al 90%, sono ripetitivi e in buona parte negativi. Sapendo questo, possiamo capire che non tutti i nostri pensieri meritano attenzione o credibilità! Esercizio: dopo aver scritto le tue preoccupazioni, prova a riformularle in modo più equilibrato. Es: il pensiero “Andrà tutto male” può diventare “Ci sono delle difficoltà, ma posso fare del mio meglio e non è detto che andrà male. Anche se non fosse perfetto, posso imparare dall’esperienza”. Coltivare questa abitudine di reframing (ristrutturazione) nel diario ti allenerà a farlo anche mentalmente durante il giorno.
- Darsi un “tempo di preoccupazione” e poi lasciar perdere: Un metodo utilizzato in psicoterapia cognitiva è quello della worry time technique. In pratica, si tratta di stabilire un momento preciso della giornata dedicato a preoccuparsi, ad esempio 15 minuti nel tardo pomeriggio, e fuori da quel momento rimandare intenzionalmente le preoccupazioni a più tardi. Se durante il giorno ti assale un pensiero ansiogeno, dillo a te stesso: “Ok, ne riparleremo nell’orario delle preoccupazioni, non adesso”. Quando poi arriva il momento stabilito, spesso accade che molte delle cose che ti tormentavano perdono urgenza o appaiono meno gravi di quanto sembrasse. Trascorso il quarto d’ora, stop: devi passare ad altro. È un esercizio di disciplina mentale, ma in molti trovano che li aiuta a contenere il rimuginio. Unito a questo, c’è un altro trucco curioso consigliato da alcuni terapeuti: tenere un elastico al polso e, quando ti sorprendi a overthinkare fuori dall’orario consentito, tirare leggermente e rilasciare l’elastico (provocando un piccolo schiocco sul polso). Questo gesto (assolutamente innocuo) funge da richiamo alla realtà e da segnale per interrompere il flusso dei pensieri ripetitivi. In alternativa, puoi usare un’app sul telefono che mandi un suono o una vibrazione a intervalli, spingendoti a verificare “Sto rimuginando? Sì? Allora mi fermo e rimando a dopo”. Sembrano stratagemmi semplici, ma aiutano a riprendere il controllo del timone mentale. Infine, assicurati di coltivare attività rilassanti nella routine serale: ad esempio, spegni le notizie e i social un’ora prima di dormire (sono spesso trigger che attivano preoccupazioni), e dedica quel tempo a una tisana, un bagno caldo, lettura leggera o stretching dolce. Una buona igiene del sonno e uno stile di vita con ritmi equilibrati (comprendendo una dieta sana e momenti di svago) costituiscono la base per una mente più tranquilla.
Mettere in pratica queste strategie richiede impegno e pazienza, all’inizio potresti non notare grandi cambiamenti, ma non scoraggiarti. Come qualunque abilità, anche la gestione dei pensieri si allena nel tempo. Puoi provare una tecnica alla volta, vedere quale funziona meglio per te e poi integrarle. Questi consigli non sostituiscono un eventuale percorso terapeutico, ma sono ottimi complementi e, nei casi lievi, possono essere sufficienti a rompere il circolo vizioso. Ogni piccolo passo (ad esempio uscire per una corsa invece di restare sul divano a rimuginare) è una conquista verso la libertà dalla mente oppressiva.
Prenota un appuntamento
Se leggendo fin qui ti sei riconosciuto in molti aspetti dell’overthinking, sappi che non sei solo e che non c’è nulla di cui vergognarsi. Milioni di persone sperimentano ogni giorno le stesse battaglie silenziose contro i pensieri che affollano la mente. La buona notizia è che esiste un aiuto concreto: con il giusto supporto, è possibile spezzare queste catene mentali e tornare a vivere con leggerezza.
Noi di My Mental Care siamo qui proprio per accompagnarti in questo percorso. Il nostro team di psicologi e psicoterapeuti qualificati può aiutarti a capire le radici profonde del tuo overthinking e fornirti gli strumenti per gestirlo. In un ambiente accogliente e riservato, potrai imparare tecniche efficaci per calmare la mente, affrontare ansie e insicurezze, e ritrovare finalmente clarità ed equilibrio.
Prenota un appuntamento: fai il primo passo verso una mente più serena. Puoi fissare un primo colloquio in cui valuteremo insieme la tua situazione e le strategie migliori per te. Non è un impegno vincolante, ma un’opportunità per ascoltarti e offrirti un orientamento personalizzato.
